|
Di
anno in anno ogni festival dedicato alla settima arte cerca di
organizzare, proporre e riflettere, più o meno parzialmente, la
condizione attuale della produzione cinematografica. Grazie ai
festival è possibile guardare il cinema senza vincoli geografici
ed elaborare un’idea più complessa e stratificata sulle forme che
permettono al cinema di manifestarsi come complesso sistema di
comunicazione e sintesi della ricerca visiva ed estetica del
presente appena trascorso. Molti fattori determinano poi la
riuscita e la graduale importanza o riconoscimento di un festival
di fronte agli altri eventi della stessa natura. E il Torino Film
Festival incarna di certo, nella sua proposta chiara e coerente
fin dal principio, e allo stesso tempo amalgama sapido e saziante
di percorsi e realtà difformi ma ugualmente necessari, una
possibilità di osservazione irrinunciabile sul cinema, perché di
rado, così come avviene in questo festival, si ha la sensazione di
poter assistere in ogni momento ad una rivelazione, o anche alla
semplice intuizione di quanto ancora si possa raccontare e
soprattutto, quanto si possa imparare da ciò che è già stato
raccontato.

Arrivato
alla ventottesima edizione, nonché la seconda sotto la direzione
artistica di Gianni Amelio (“Il direttore di un festival alla
seconda esperienza può cadere nella trappola di volere di tutto e
di più...”) anche quest’anno la rassegna torinese è riuscita a
incanalare nelle numerose sezioni, opere e autori che - come
spesso capita, a conti fatti - meriterebbero più
di
uno sguardo critico.
 Ed
è proprio questo addensamento variegato e difforme di titoli a
costituire l’indomita peculiarità del festival torinese. Una
realtà in grado di descrivere
e organizzare, di anno in anno, il cinema nella sua totalità, di
sguardo, di ricerca, di memoria, di commercio, e, in definitiva,
di raccontare un’incombenza come fosse una dichiarazione d’amore,
dovuta e spontanea. Ed
è proprio questo addensamento variegato e difforme di titoli a
costituire l’indomita peculiarità del festival torinese. Una
realtà in grado di descrivere
e organizzare, di anno in anno, il cinema nella sua totalità, di
sguardo, di ricerca, di memoria, di commercio, e, in definitiva,
di raccontare un’incombenza come fosse una dichiarazione d’amore,
dovuta e spontanea.
Dieci le sezioni principali del festival
Il
Concorso ufficiale
come sempre dedicato solo alle opere prime e seconde, qualche
volte terze, con sedici film in competizione per i premi assegnati
dalla giuria presieduta da Marco Bellocchio.
Winter’s
Bone, solido e
raggelato dramma familiare dell’indipendente Debra Granik, ha
vinto meritatamente come miglior film e miglior attrice per
l’interpretazione di Jennifer Lawrence (già vincitrice del premio
Marcello Mastroianni come miglior attrice emergente a Venezia 65
per
The Burning Plain
di Guillermo Arriaga). Tra le visioni più interessanti è d’obbligo
ricordare l’opera seconda della giovane regista canadese Sophie
Deraspe,
Les Signes
Vitaux, dramma
lucido e profondo sulla morte condotto con accurata ricerca
estetica in bilico fra documentario e ricerca psicologica; il
doloroso e toccante viaggio spirituale di
Last
Chestnuts di Zhao Ye,
regista cinese già presente in concorso a Torino nel 2009 con
Jalainur, qui in trasferta nella città di Nara in Giappone, per un
cimentarsi col progetto NARAtive creato da Naomi Kawase; e
Vampires
del belga Vincent Lannoo, arguto e inaspettato mockumentary sulla
quotidianità di una famiglia di vampiri, un espediente originale e
divertente che riesce a mescolare documentario, B-movie, commedia
e a criticare ferocemente le contraddizioni e le colpe della
contemporaneità.
  
Festa
Mobile divisa
al suo interno tra
Figure nel paesaggio
e
Paesaggio con figure
per distinguere i film di finzione da quello documentari,
rappresenta la sezione più corposa e il contenitore poliedrico
dentro il quale gravitano firme riconosciute e  prestigiose. Dall’esasperazione rabbiosa di Koji Wakamatsu con
Caterpillar,
a quella fantasmagorica e pop di Gregg Araki con
Kaboom,
passando dal sublime incontro con il mesto destino in
Poetry
di Lee Chang-dong, alle riflessioni sulla morte in
Hereafter
di Clint Eastwood.
La percezione della fine, nelle sue varie forme, sembra
attraversare il cinema come un’urgenza necessaria di questi tempi.
prestigiose. Dall’esasperazione rabbiosa di Koji Wakamatsu con
Caterpillar,
a quella fantasmagorica e pop di Gregg Araki con
Kaboom,
passando dal sublime incontro con il mesto destino in
Poetry
di Lee Chang-dong, alle riflessioni sulla morte in
Hereafter
di Clint Eastwood.
La percezione della fine, nelle sue varie forme, sembra
attraversare il cinema come un’urgenza necessaria di questi tempi.
Ma con
Misterios de
Lisboa
(tratto dall'omonimo classico della letteratura portoghese di
Camilo Castelo Branco pubblicato nel 1854), Raoul Ruiz ci ricorda
ancora una volta quanto la finitezza del cinema costituisca lo
stimolo, ipnotico e conturbante, per una ricreazione immortale
dell’immagine dal nostro sguardo. E con uno sguardo analitico e
sincero si pone di fronte ai suoi adolescenti l’esordiente David
Robert Mitchell che con
The Myth of the American Sleepover
ripercorre la strada della commedia per ragazzi con una
sensibilità, una profondità e una leggerezza rare e degne di
rimanere impresse nella memoria.
 
Non altrettanto indimenticabile l’esordio alla regia di Philip
Seymour Hoffman che con
Jack Goes Boating
porta sullo schermo senza sbavature né eccessi la pièce teatrale
di Bob Glaudini sul farsi e il disfarsi dei rapporti di coppia
sullo sfondo di una gelida New York dei nostri giorni, e si fa
portavoce di un cinema che pone al centro le indubbie doti
interpretative sei suoi attori. Dai toni diametralmente opposti
invece
Super
di James Gunn, divertentissima e nient’affatto banale
commedia su patetico uomo costretto a diventare un atipico e
normalissimo supereroe per cercare di riconquistare la moglie che
l’ha lasciato; tra una risata e l’altra, un vero percorso
formativo non così scontato e assurdo come potrebbe apparire, con
due interpreti - Ellen Page e Rainn Wilson - decisamente
funzionali nella loro forsennata malleabilità slapstick.
 
Rapporto Confidenziale,
sezione monografica dedicata quest’anno al genere horror “che,
dopo anni di convenzionali riciclaggi occidentali di suggestioni,
filoni, stravaganze orientali, ricomincia a dare segni di vitalità
e inventiva. Una vitalità che trapela
 anche
scavando nella massa magmatica del cinema giovane e indipendente,
dove spesso viene enfatizzata da una gamma stilistica a tematica
variatissima”. Dunque una nuova ondata di horror che vede però
come suo principale esponente il ritorno di un autore cult come
John Carpenter, di nuovo al cinema nove anni dopo
Fantasmi da
Marte, capostipite dagli anni Settanta di un genere
di volta in volta rinnovato e modificato e mai stancamente fermo e
riproposto come emblema di un marchio di fabbrica.
The Ward
è del tutto fedele ai principi del cinema carpentiariano e il
discorso sulla paura passa attraverso le oscure voragini della
mente per divenire concetto ed estetica che travalicano le
costrizioni dello schermo per proiettarsi direttamente dentro al
corpo di chi guarda. Ogni scena di The Ward
esemplifica una costruzione formale che trascende il discorso
narrativo finalizzato a una suspance dell’inatteso, del colpo di
scena, dell’orrido figurativo realisticamente proposto come trofeo
riconciliante della presa di coscienza dell’ignoto, e propone una
visione della follia come complesso rapporto di sguardi e
dialettica col mezzo cinematografico. “Un horror di vecchia
scuola, fatto da un regista della vecchia guardia” lo
definisce lo stesso Carpenter. Sicuramente l’horror più innovativo
e potente tra tutti quelli inseriti nel programma della sezione. anche
scavando nella massa magmatica del cinema giovane e indipendente,
dove spesso viene enfatizzata da una gamma stilistica a tematica
variatissima”. Dunque una nuova ondata di horror che vede però
come suo principale esponente il ritorno di un autore cult come
John Carpenter, di nuovo al cinema nove anni dopo
Fantasmi da
Marte, capostipite dagli anni Settanta di un genere
di volta in volta rinnovato e modificato e mai stancamente fermo e
riproposto come emblema di un marchio di fabbrica.
The Ward
è del tutto fedele ai principi del cinema carpentiariano e il
discorso sulla paura passa attraverso le oscure voragini della
mente per divenire concetto ed estetica che travalicano le
costrizioni dello schermo per proiettarsi direttamente dentro al
corpo di chi guarda. Ogni scena di The Ward
esemplifica una costruzione formale che trascende il discorso
narrativo finalizzato a una suspance dell’inatteso, del colpo di
scena, dell’orrido figurativo realisticamente proposto come trofeo
riconciliante della presa di coscienza dell’ignoto, e propone una
visione della follia come complesso rapporto di sguardi e
dialettica col mezzo cinematografico. “Un horror di vecchia
scuola, fatto da un regista della vecchia guardia” lo
definisce lo stesso Carpenter. Sicuramente l’horror più innovativo
e potente tra tutti quelli inseriti nel programma della sezione.

Onde, occhi aperti sul presente
(del Cinema) è la sezione che opera “in quel limbo
difficilmente definibile che sta tra tecnica e linguaggi, generi e
formati, supporti e archivio, realtà più piena e finzione più
estrema, paesaggi e figure che hanno la consistenza di carne e
sangue della Storia e delle persone, ma possono anche
smaterializzarsi nella sostanza delle pure immagini, della
pellicola (ri)trovata, dell’emulsione e del pixel, del tratto che
disegna e si anima e dell’archivio che risorge e si rianima”.
E in questa terra di confini e contaminazioni a volte indefinibili
e sfuggenti, risplende di una luce morbida ed evocativa un’altra
opera nata all'interno del progetto
NARAtive del Nara International Film festival
e già vincitrice del premio speciale
 della
giuria al festival del cinema asiatico di Nagaoka:
Bion
di Toyoko Yamasaki è un piccolo gioiello capace di evocare
sentimenti e sensazioni primordiali e un’immersione perturbante in
un ambiente (nei dintorni appunto della città di Nara) che sembra
l’anticamera di un sogno. E come in un sogno è predominante in
questo raccontino l’elemento della memoria che ritorna quando la
giovane protagonista Shiho rivede la madre che l’ha abbandonata e
sperimenta il dolore di un legame che non c‘è più. Seguendo una
strada già battuta da Naomi Kawase anche
Toyoko
Yamasaki punta il
proprio sguardo sul complesso rapporto dell’uomo con la natura e
da questa insistita osservazione emerge la vita, e le sensazioni
ad essa associate vengono isolate e letteralmente amplificate.
“Ho prestato attenzione agli splendidi suoni della vita quotidiana
in modo che il pubblico fosse maggiormente in grado di percepirne
l’odore e l'umore. Suoni come quelli legati al cucinare, piallare,
tagliare la legna da ardere, a un falò, a una campana, al vento e
alla pioggia, al fruscio di un bosco di bambù e al cinguettio di
piccoli uccelli”. della
giuria al festival del cinema asiatico di Nagaoka:
Bion
di Toyoko Yamasaki è un piccolo gioiello capace di evocare
sentimenti e sensazioni primordiali e un’immersione perturbante in
un ambiente (nei dintorni appunto della città di Nara) che sembra
l’anticamera di un sogno. E come in un sogno è predominante in
questo raccontino l’elemento della memoria che ritorna quando la
giovane protagonista Shiho rivede la madre che l’ha abbandonata e
sperimenta il dolore di un legame che non c‘è più. Seguendo una
strada già battuta da Naomi Kawase anche
Toyoko
Yamasaki punta il
proprio sguardo sul complesso rapporto dell’uomo con la natura e
da questa insistita osservazione emerge la vita, e le sensazioni
ad essa associate vengono isolate e letteralmente amplificate.
“Ho prestato attenzione agli splendidi suoni della vita quotidiana
in modo che il pubblico fosse maggiormente in grado di percepirne
l’odore e l'umore. Suoni come quelli legati al cucinare, piallare,
tagliare la legna da ardere, a un falò, a una campana, al vento e
alla pioggia, al fruscio di un bosco di bambù e al cinguettio di
piccoli uccelli”.
 Per
la sezione dedicata ai documentari italiani
Italiana Doc
hanno vinto Gianluca e Massimiliano De Serio per
Bakroman.
I gemelli torinesi sono tra i nomi più promettenti del nuovissimo
cinema italiano: dal 1999 realizzano insieme cortometraggi e
documentari e hanno ricevuto riconoscimenti da festival di tutto
il mondo. In lingua moré, quella parlata nel Burkina Faso, il
termine bakroman significa “ragazzo di strada”. Sono più di
seicento i ragazzi che vivono senza niente da mangiare, né un
tetto sotto cui dormire, per le strade di Ouagadougou, la capitale
dello stato. Eppure, per difendere i propri diritti e coltivare le
proprie speranze. si sono uniti in una sorta di sindacato che
sembra rendere più concreta la possibilità, un giorno, di
affrancarsi da quella condizione. Per
la sezione dedicata ai documentari italiani
Italiana Doc
hanno vinto Gianluca e Massimiliano De Serio per
Bakroman.
I gemelli torinesi sono tra i nomi più promettenti del nuovissimo
cinema italiano: dal 1999 realizzano insieme cortometraggi e
documentari e hanno ricevuto riconoscimenti da festival di tutto
il mondo. In lingua moré, quella parlata nel Burkina Faso, il
termine bakroman significa “ragazzo di strada”. Sono più di
seicento i ragazzi che vivono senza niente da mangiare, né un
tetto sotto cui dormire, per le strade di Ouagadougou, la capitale
dello stato. Eppure, per difendere i propri diritti e coltivare le
proprie speranze. si sono uniti in una sorta di sindacato che
sembra rendere più concreta la possibilità, un giorno, di
affrancarsi da quella condizione.
Mentre la sezione dedicata ai cortometraggi italiani
Italiana Corti
ha vinto
Archipel
di Giacomo Abbruzzese, storia di un giovane palestinese che di
notte entra illegalmente a Gerusalemme attraverso il sistema
fognario che passa sotto al muro che divide la città.
Figli e amanti,
ovvero cinque registi italiani hanno presentato un film che è
stato fondamentale per la nascita della loro ispirazione e della
loro voglia di diventare cineasti, per la loro formazione
culturale e cinematografica, per la loro maturazione stilistica:
Carlo Verdone Lo sceicco bianco di Federico Fellini,
Saverio Costanzo L’angelo sterminatore di Luis
Bunuel, Daniele Luchetti Se... di Lindsay Anderson,
Carlo Mazzacurati Il lungo addio di Robert Altman,
Dario Argento Kinoglaz di Dziga Vertov.
|
Concludono il
programma le due
retrospettive
sull’intera opera di due autori diversissimi tra loro: |
|
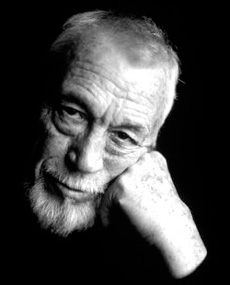
“John
Huston, nato
a Nevada, nel Missouri, nel 1906, morto nel 1987, pochi mesi
prima che uscisse il suo ultimo capolavoro: The Dead,
da un racconto di
Gente di Dublino di James Joyce. Boxeur, giornalista,
scrittore, pittore (da giovane, a Parigi, dove si trasferì
per studiare arte e dove, rimasto senza un soldi, visse
ritraendo i passanti, e in vecchiaia, nel buen retiro
messicano di Las Caletas), sceneggiatore (dei propri film e
di molti altri, a Hollywood negli anni Trenta), attore
(ancora, nei propri film e, soprattutto nella maturità, in
moltissimi di altri registi, che interpretava perché lo
pagavano molto bene), e soprattutto regista, di trentotto
film che hanno attraversato e segnato, tra il 1941 e il
1987, la storia del cinema contemporaneo”. |
“Il nome di
Vitalij Kanevskij
riecheggia con forza e grande rispetto tra i cinefili. Fu di
grande impatto, circa vent’anni fa, la visione al festival
di Cannes 1990 del suo lungometraggio Sta’ fermo, muori e
resuscita che gli valse, a cinquantacinque anni, la
Camera d’or, il premio destinato alla migliore opera prima.
Fu un riconoscimento fortemente voluto per l’irruente forza
di un film che nasceva, citando le dichiarazioni
dell’autore, come il respiro di un uomo che riemerge dagli
abissi trasmettendo la forza di chi non vuole soccombere. E
che documentava con un duro stile neorealistico l’orrore
della città prigione dell’estremo Est sovietico nel periodo
più buio dello stalinismo. Fu inevitabilmente anche un
premio per tutti quegli autori che cominciavano a mostrare
la realtà dell’Unione Sovietica al di là della cortina di
ferro e della propaganda e che in quel contesto avevano
lottato strenuamente, spesso invano, per tentare di
affermare le loro idee. Fu quindi anche un riconoscimento
assegnato a quello che era intuitivo chiamare il cinema
«della perestrojka», sempre più visibile mentre l’Unione
Sovietica si avviava verso il suo definitivo collasso, e
quel film divenne, in uno slancio naturale, il vessillo di
quel cambiamento”.
 |
|