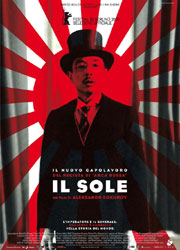|
Dopo
Hitler e Lenin, col potente Hirohito visto nella sconfitta post bellica
mentre tratta con un disponibile McArthur, Sokurov
 chiude la sua
fantastica trilogia sugli individui cosmico storici, come diceva Hegel
(forse ci sarà anche Faust). Vede il 120° imperatore della divina dinastia
come un venerato manichino che rinuncia alla propria aureola e al sole
deludendo, in data 1 gennaio '46, il popolo pronto al martirio. E si
rivela un essere umano triste, paradossale, umoristico e paranoico, volto
al dettaglio e al privato, dopo aver vissuto il mondo in prima persona.
Nel silenzio-penombra del bunker Sokurov organizza la ieratica, disperata
recita in un film claustrofobico, di forma sconvolgente e mai disgiunta da
un preciso discorso sui riti pubblici e privati, su caos e metodo, sulla
misteriosa psicologia di un «idiota» dostoevskijano, un bambino indifeso
nel profondo, non a caso paragonato al clown Charlot. chiude la sua
fantastica trilogia sugli individui cosmico storici, come diceva Hegel
(forse ci sarà anche Faust). Vede il 120° imperatore della divina dinastia
come un venerato manichino che rinuncia alla propria aureola e al sole
deludendo, in data 1 gennaio '46, il popolo pronto al martirio. E si
rivela un essere umano triste, paradossale, umoristico e paranoico, volto
al dettaglio e al privato, dopo aver vissuto il mondo in prima persona.
Nel silenzio-penombra del bunker Sokurov organizza la ieratica, disperata
recita in un film claustrofobico, di forma sconvolgente e mai disgiunta da
un preciso discorso sui riti pubblici e privati, su caos e metodo, sulla
misteriosa psicologia di un «idiota» dostoevskijano, un bambino indifeso
nel profondo, non a caso paragonato al clown Charlot. |
|
Dopo
averci introdotto agli ultimi giorni di Hitler (Moloch)
e di Lenin (Taurus,
inedito in Italia), Aleksandr Sokurov ci guida a conoscere quelli
dell'imperatore Hirohito. Ultimi giorni non da uomo, ma da divinità;
perché Hirohito muore come dio per risorgere come uomo. Il secondo è molto
più potente del primo: rinunciando pubblicamente allo status divino
attribuito ai sovrani nipponici, l'uomo nuovo riuscì a risparmiare le vite
di migliaia di soldati, disarmandoli e ponendo fine al conflitto mondiale.
L'opposto di quanto fece Hitler, che mandò al massacro i resti del suo
esercito a guerra ormai perduta.
Per intuire quanto la decisione fosse difficile, basterà ricordare che
Il
sole stenta a uscire in Giappone, causa le minacce a distributori ed
esercenti considerati complici dell'infrazione di un tabù (ed è oggetto di
minacce di morte l'attore Issey Ogata, per aver osato impersonare
l'imperatore).
Se il film è un capolavoro, ciò dipende dal modo unico con cui il regista
russo mette in scena eventi tanto grandi. Con la sua cinepresa entriamo
nell'intimità del piccolo grande uomo, che agli occupanti americani fa
venire in mente Charlot: un gentleman minuto, appassionato di
idrobiologia, collezionista d'immagini delle star di Hollywood, afflitto
da tic nervosi, vestito e svestito dalla servitù ma anche
straordinariamente coraggioso, consapevole e generoso. Il più atipico dei
"tiranni", assai meno posseduto dal proprio ego di qualsiasi politico
odierno.
Il film consta di un numero limitato di scene, dall'appello per la
cessazione delle ostilità ai colloqui tra Hirohito e il generale MacArthur,
comandante delle forze alleate in Giappone; fino al ricongiungimento,
pudicamente affettuoso, con l'imperatrice.
Occorre sottolineare che semplicità, in Sokurov, non è sinonimo di
facilità. Al contrario. Chi nel cinema cerca intrattenimento e distrazione
potrebbe trovarsi spiazzato davanti alle immagini in penombra, al ritmo
piano, alle scelte anti-spettacolari. O invece potrebbe lasciarsi
conquistare da un cinema così diverso da quello corrente, meditato e
prezioso, inaspettato eppure necessario. |
|
Aleksandr
Sokurov ha completato la trilogia dei dittatori Hitler era
Moloch (1999), nome
che per gli antichi fenici designava il sacrificio rituale dei bambini.
Uno sfinito Lenin era Taurus
(2000). Adesso arriva nelle sale
Il
Sole,
dedicato all’imperatore giapponese Hirohito, 124esimo discendente della
dea del sole Amaterasu. Hitler muore nel bunker della Berlino distrutta.
Lenin muore nel suo letto, Hirohito annuncia il 15 agosto del 1945 la resa
del Giappone dopo Hiroshima. Per la prima volta fa sentire la sua voce,
per radio, per dichiarare finita la guerra. Il Giappone imperiale scende a
patti con il generale McArthur. Sokurov è attratto dai personaggi che
hanno esercitato il potere con il terrore, le stragi, il sangue e le
guerre: anche dentro una crepuscolare e fantasmatica luce di celeste
distanza, come il regista immagina sia accaduto con Hirohito. Sokurov è
affascinato dall’aspetto quotidiano e banale del potere, dalla vita che
Hitler, Lenin e l’imperatore conducono nelle loro stanze, in una intimità
che ne rivela l’incerta natura, le debolezze e la piccolezza. Cosa si
dicevano Hitler ed Eva Braun nella villa fortilizio di Berchtesgaden, di
cosa chiacchieravano con Bormann e Goebbels mentre i camini di Auschwitz
filmavano senza sosta. Com’è il potere nella sua veste familiare, quando
Eva Braun può prendere a calci il suo piccolo dittatore. Cosa si dicevano,
nel 1922, il moribondo e impotente Lenin e il rampante e sorridente
Stalin. Cosa pensava Lenin nella sua lunga agonia, circondato da
infermieri e spie. Sokurov è stregato dall’altra faccia delle cose. Dalla
faccia nascosta della grande storia, come dall’altra faccia di ogni
esistenza celata dall’opacità di un volto. Guarda dietro le cose, si
interroga sulla storia del suo mondo, russo e sovietico, cerca rifugio
nell’elegia, nell’incanto di un paesaggio nebbioso. Si immagina lo
splendore rifulgente del potere e la sua marcia cancrena.
Nato in Siberia, vicino a Irkutsk nel 1951, ha diretto dal 1978 a
oggi una quindicina di film di finzione e una trentina di lavori di
vario genere, documentari ed “elegie”. Cineasta affascinato dalla
leggerezza di ciò che è effimero e dalla pesantezza di ciò che è potente,
sperimenta tecniche nuove, sa fondere immagini di repertorio con altre
di finzione, ama la vecchia Russia, per la quale prova compassione
e rimpianto, si abbandona alla commozione quando traccia i ritratti
parentali di
Madre e figlio
(1997) e di
Padre e figlio
(2003). È stato Andrej Tarkovskij ad aiutare il giovane Sokurov in
difficoltà con le autorità sovietiche che non volevano saperne di
lasciar circolare il suo primo film, La
voce solitaria dell’uomo, pronto
nel 1978, uscito soltanto nel 1987. Formalismo, manierismo, intellettualismo,
le solite accuse. Stupide. Dopo la scomparsa di Tarkovskij, è Sokurov
a continuare quel percorso di scavo e di preservazione di tutto quello
che ci viene alla mente quando pensiamo la parola Russia. Canti, salmodie
ed elegie nella spettrale Elegia sovietica
(1989), nell’intensa Elegia
moscovita (1989), nella lirica Elegia
semplice (1990), con la lunga sequenza
del presidente lituano Landsbergis che suona il piano, nel vuoto della
storia. Documentari commoventi come quello sull’inaugurazione del
monumento a Dostoevskij, a San Pietroburgo. Viaggi nell’arte e nella
storia come in
Arca russa
(2002), itinerario senza stacchi dentro il museo dell’Hermitage, tra
personaggi che emergono dal passato e un ballo alla corte dello zar
che è sontuosa rievocazione, nostalgica meditazione e addio definitivo
a un mondo inghiottito dalle nebbie del tempo. E testimonianze amorevoli
di affetto verso altri artisti, come il documentario che registra,
senza commenti, un’esecuzione del
Requiem di
Mozart (2004). Sokurov è astratto e realista, lirico e documentaristico,
si volta nostalgicamente indietro per rimanere ben dentro la tradizione
ed è già tecnologicamente avanti (Scorsese
l’ha definito «un pioniere nelle tecnologie»). Ci ridà la sanguinaria
pesantezza della storia, il rumore del tempo, l’elegiaca dolcezza
di un attimo. Ci ricorda che «l’arte non è mai vecchia o nuova,
è semplicemente eterna».
|