|
|

Sacile, ultimo atto
Maria Cristina Nascosi
Davvero
un festival in progress quello delle
Giornate
del Cinema Muto
di
Sacile
che dal prossimo anno tornerà alla sede originaria di Pordenone. Questa XXIII edizione (9-16
ottobre)
ha continuato ad offrire retrospettive già note ed ormai entrate nella
tradizione come il
Griffith Project 8,
che ha proposto la produzione del 1915 comprendente anche
The Birth of a Nation.
Ma il vero evento da segnalare è
Vertov at Work: pictures, papers, posters, poems,
rassegna dedicata a Dziga Vertov, la più completa mai proposta finora in
Italia.
Oltre alle proiezioni ed alla pubblicazione di un poderoso volume
monografico sul grande Autore, durante le Giornate è stato possibile
visionare una mostra allestita nella Sala Affreschi di Palazzo Flangini
Biglia. Tra i materiali in esposizione, tutti provenienti dal Filmmuseum
di Vienna, figuravano lettere, saggi, recensioni pubblicate su riviste
d’epoca, fotografie e, soprattutto, posters originali delle pellicole di
Vertov.
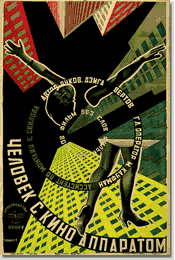
Così ce lo descrive in catalogo, tra l’altro, Yuri Tsivian, il migliore
conoscitore del cinema muto russo, ben noto ai fan di Sacile, ed autore
del testo monografico: “…Dziga Vertov è uno di tre-quattro nomi che
inevitabilmente si fanno in qualunque conversazione sul cinema muto
sovietico, ma diciamocelo: molti di noi conoscono Vertov solo per pochi
film. Questa sola è una ragione sufficiente per vederne di più, ma nel
caso di Vertov ce n’è un’altra. Si può dire di capire davvero L’uomo con
la macchina da presa – anche se lo si conosce come il palmo della propria
mano – finché non si sono visti, diciamo, Kino-Pravda N.18 o il
Goskinocalendar N.47? Vertov direbbe di no, perché questo cineasta aveva
la peculiare abitudine di negare che il suo lavoro riguardasse la
realizzazione di film singoli o, se per questo, la realizzazione di film
tout court. “Kino-Glaz (Cine-occhio) non è una pellicola cinematografica,
né un gruppo di addetti ai lavori, né una corrente artistica (di sinistra
o di destra)”, spiegava Vertov nel suo messaggio ai compagni kinoc ( i
“cine-occhi”, come Vertov definiva se stesso ed i suoi collaboratori dalla
mentalità simile), durante l’incontro del gennaio 1926. (…) Per concludere
, il cine-occhio non è un film e nemmeno un gruppo di film: è un
movimento, un’attività, un progetto (…)”. |
|

Uno
sguardo, un maestro
Alessandro Tognolo
Il
cinema, si sa, trae il suo nutrimento endogeno dallo sguardo dello
spettatore. Senza la possibilità di mostrarsi, di farsi analizzare,
di scoprirsi per la sua essenza autoriale, il cinema non vivrebbe.
Non solo i grandi festival cercano di promuovere questa cultura
e quest'arte (per fortuna) e, anzi, l’irrequieto proliferare di
iniziative – ognuna con una specifica attitudine – su tutto il
territorio nazionale, fornisce un concreto apporto per la destrutturazione
di una certa cultura cinematografica, merceologica e imperante.
Si può collocare in quest’ottica la settima edizione del
Lo sguardo dei maestri
(novembre
2004 - febbraio 2005),
promossa dal
Centro Espressioni Cinematografiche
di Udine e dall’associazione culturale
Cinemazero
di Pordenone, dedicata quest'anno all’opera complessa di un indiscusso
maestro qual è
Ingmar Bergman . .
Una retrospettiva completa sulla sua filmografia e un convegno incentrato
sull’opera multiforme dopo l’ufficiale congedo dal cinema del 1982, con
Fanny e Alexander.
Un addio ingannevole dopo la realizzazione controversa di un capolavoro,
un concentrato delle passioni, della vita, dei temi cari al regista
scandinavo. Un addio amaro, segnato dalle difficoltà distributive che il
profluvio creativo incontenibile di Fanny e Alexander (oltre le quattro
ore) incontrava per il suo essere esasperatamente e prettamente cinema,
personale, dell’anima, e non commercialmente appetibile. Un addio (e a
questo punto possiamo davvero ribadirlo) fasullo, incapace a sostenersi
proprio per l’inesauribile voglia, volontà, necessità, dovere di svelarsi
e compiersi attraverso le immagini, nel loro valore automaticamente
identificativo - amore bergmaniano primordiale – che si cost(it/r)uisce
attraverso le parole. Sono proprio le parole – e la produzione del Bergman
scrittore ne è la chiara dimostrazione – il motore fondativo delle
immagini, l’espressione con la quale Bergman non verrà mai a compromessi,
la possibilità di emanarsi a dismisura attraverso sceneggiature (è sua
quella, splendida, de
L’infedele
di Liv Ullmann), pièces teatrali, romanzi, autobiografie. Il congedo per
Bergman ha significato un ritorno al teatro, una riappropriazione naturale
e inequivocabile verso una passione innata e mai cessata – e del resto,
non a caso, ne sono un palpitante segno gli occhi sognanti di Alexander,
in apertura di Fanny e Alexander, mentre penetrano il teatrino oggetto di
svago, emblema e archetipo di un’illusione che, in varie forme, ricorrerà
per tutto il film. È col teatro che nel 1984 Bergman, rievocando il
“Sogno” di Strindberg torna a fabbricare immagini in movimento:
Dopo la prova
segna l’avvio verso un percorso nel quale si confronterà con la nuova
tecnologia digitale e la nuova destinazione televisiva. Un percorso che,
ancora una volta, analizza e sviscera le relazioni umane, di eccezionale
acume d’indagine intellettuale e psicologica, dove i diversi piani
dell’esistenza e della rappresentazione scaturiscono i conflitti
interiori; dentro le ossessioni e la follia della mente, dentro gli
intrecci sentimentali, muovendosi – senza indugi e con una naturalezza
impercettibili – tra gli scambievoli legami delle diverse generazioni.
Con
Il segno
(1986) Bergman torna a Uppsala (sua città natale) per mostrarci
limpidamente l’evolversi la storia di un amore assoluto, total(izzant)e,
preda di un incubo religioso esasperante, dove il maligno risiede in una
macchia scusa nell’occhio. Il Segno, nuovamente, riprende molti temi cari
al regista, ribadendo questa caratteristica come una costante stilistica
del fare cinema bergmaniano. Una modalità espressiva per duellare con il
proprio passato e per riflettere sul presente, senza il bisogno di fornire
soluzioni semplicistiche o sagge considerazioni ideali. Spesso la via
d’uscita è tragica, sconfortante, amareggiante, ma non per questo unicamente pessimistica.
Vanità e affanni
(1997) rappresenta un filo diretto con
Fanny e
Alexander:
lo zio burlone e sguaiato Carl, con un animo fanciullo, offre a Bergman la
possibilità di perpetrare uno sviluppo riflessivo sulle due forme
costitutive dell’espressività dell’autore.
|
|
|
Cinema e teatro si mescolano con la vita stessa di Carl, prendendone le
mosse, autodefinendosi, codificandosi – la realizzazione di un film
parlato dal vivo è il progetto di Carl, che già in
Fanny e
Alexander
aveva regalato la magia di un proiettore al giovane protagonista - e
riallacciandosi al meccanismo del racconto intimista che sarà assunto fino
in fondo con
 Sarabanda
(2003). Un saluto quasi definitivo, per lo spessore dei contenuti e
l’eccezionale costruzione formale, Bergman sembra ribadirlo
definitivamente proprio con
Sarabanda.
A nulla importa che la sua destinazione sia la televisione, dentro c’è
tutta la sensibilità del vecchio (ma non per questo meno lucido) Bergman.
Un percorso che attraversa la sua creazione, riesaminandola con nuove
prospettive e, perciò, ampliandola. Ritroviamo - ancora una volta - in
Sarabanda, gli attori cari al regista, quasi come fossero una compagnia
che di volta in volta porta in scena un nuovo spettacolo. Attraverso gli
sguardi di Liv Ullmann e Erland Josephson, si ha la netta sensazione di
non far parte di una messa in scena, e proprio grazie a questa intensa
naturalezza espressiva e registica opposta al contrastante rigore del set
artificiale, Bergman riesce a produrre uno straordinario esempio di cinema
capace di specchiarsi negli occhi di chi guarda. Bastano piccoli
movimenti, cenni d’intesa per far esplodere la tensione drammatica e, allo
stesso tempo, stabilire l’ordine. Dopo
Sarabanda, Bergman – queste le sue
parole - si godrà la sua vita nell’isola di Faro a scrivere e guardare i
film degli altri. Sarabanda
(2003). Un saluto quasi definitivo, per lo spessore dei contenuti e
l’eccezionale costruzione formale, Bergman sembra ribadirlo
definitivamente proprio con
Sarabanda.
A nulla importa che la sua destinazione sia la televisione, dentro c’è
tutta la sensibilità del vecchio (ma non per questo meno lucido) Bergman.
Un percorso che attraversa la sua creazione, riesaminandola con nuove
prospettive e, perciò, ampliandola. Ritroviamo - ancora una volta - in
Sarabanda, gli attori cari al regista, quasi come fossero una compagnia
che di volta in volta porta in scena un nuovo spettacolo. Attraverso gli
sguardi di Liv Ullmann e Erland Josephson, si ha la netta sensazione di
non far parte di una messa in scena, e proprio grazie a questa intensa
naturalezza espressiva e registica opposta al contrastante rigore del set
artificiale, Bergman riesce a produrre uno straordinario esempio di cinema
capace di specchiarsi negli occhi di chi guarda. Bastano piccoli
movimenti, cenni d’intesa per far esplodere la tensione drammatica e, allo
stesso tempo, stabilire l’ordine. Dopo
Sarabanda, Bergman – queste le sue
parole - si godrà la sua vita nell’isola di Faro a scrivere e guardare i
film degli altri.
Non si sa però se resisterà alla tentazione di mettersi
di nuovo alla prova, per l’ultima volta. |