|
Lo scorso Natale siamo stati in
Israele e Palestina
con un viaggio
organizzato da Al-Quds, associazione di cultura Italo-Palestinese
e ciò che abbiamo visto ci impone di testimoniare: eravamo già a
conoscenza della situazione socio-politica, ma vedere con i nostri occhi
la realtà ci ha fatto capire più approfonditamente cosa stia succedendo in
quelle terre. Sarebbe meglio dire cosa stava succedendo, visto che ormai
sono passati alcuni mesi dal nostro viaggio, mesi densi di cambiamenti, o
più precisamente di eventi che hanno fatto presagire, che hanno promesso,
che fanno sperare in qualche cambiamento. Purtroppo, per la maggior parte,
la situazione che abbiamo incontrato è ancora attuale; per questo
parleremo del nostro viaggio al presente, per permettervi di entrare
meglio nella realtà che noi abbiamo sperimentato, per poi fare chiarezza
su ciò che ora sembra essere diverso.
Siamo stati in Israele e nei Territori Palestinesi per circa una
settimana: abbiamo prima soggiornato a Betlemme e poi a Gerusalemme,
sfruttando queste due città come punti di partenza per le nostre visite,
ma al di là del racconto del viaggio o della descrizione dei luoghi, ci
teniamo a trasmettervi quello che abbiamo compreso della vita, nei suoi
vari aspetti, in quei paesi.
Elena e Mattia L. |
 Diario di viaggio Diario di viaggio
L’impressione generale che deriva da quanto visto è che il governo
israeliano, con la motivazione di garantire la sicurezza dello stato, stia
in realtà mettendo in atto nei confronti del popolo palestinese un
processo di graduale ghettizzazione, che sembra tendere al completo
annientamento di quella gente, sul piano sia morale che fisico, e alla
distruzione di qualsiasi possibilità di realizzazione dello “stato
palestinese”. L’elemento più significativo di questa linea di condotta,
sia da un punto di visto simbolico che a livello materiale, è la
costruzione del famigerato
muro di
separazione, un mostro alto 8 metri che
chiude in
una morsa sempre più stretta i palestinesi e la loro terra. Questo
abominio, che viene presentato come una “barriera difensiva”, si rivela in
realtà
uno strumento molto efficace per tre scopi: l’occupazione, la
segregazione, e l’indebolimento dell’economia agricola.
Innanzitutto, il
percorso del muro
non sta seguendo la cosiddetta “linea verde”, il confine pre-1967,
ma ingloba sempre più territori, espropriando terreni coltivati, o
comunque fertili, e pure risorse idriche; inoltre per costruirlo
vengono abbattuti migliaia di alberi di olivo, fonte primaria di
sostentamento di molte famiglie e perno dell’economia palestinese. morsa sempre più stretta i palestinesi e la loro terra. Questo
abominio, che viene presentato come una “barriera difensiva”, si rivela in
realtà
uno strumento molto efficace per tre scopi: l’occupazione, la
segregazione, e l’indebolimento dell’economia agricola.
Innanzitutto, il
percorso del muro
non sta seguendo la cosiddetta “linea verde”, il confine pre-1967,
ma ingloba sempre più territori, espropriando terreni coltivati, o
comunque fertili, e pure risorse idriche; inoltre per costruirlo
vengono abbattuti migliaia di alberi di olivo, fonte primaria di
sostentamento di molte famiglie e perno dell’economia palestinese. |
|
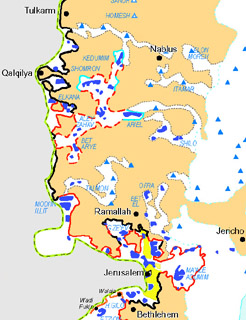 L’occupazione
realizzata grazie al muro è poi integrata da un’altra strategia, che
abbiamo visto in azione quotidianamente: la continua creazione all’interno
dei territori palestinesi, di
insediamenti
israeliani, chiusi da recinzioni, con ingressi sorvegliati che negano
l’ingresso ai palestinesi e raggiungibili, a volte, solo da strade
private, la cui costruzione implica ulteriori espropri. Questi nuovi
villaggi stanno progressivamente occupando, ad esempio, tutte le sommità
delle colline attorno a Betlemme e in generale sorgono ovunque;
all’interno di questi insediamenti si vedono spesso edifici vuoti, il che
fa supporre che lo scopo principale sia proprio prendere possesso dello
spazio, più che fornire nuovi spazi abitativi. L’occupazione
realizzata grazie al muro è poi integrata da un’altra strategia, che
abbiamo visto in azione quotidianamente: la continua creazione all’interno
dei territori palestinesi, di
insediamenti
israeliani, chiusi da recinzioni, con ingressi sorvegliati che negano
l’ingresso ai palestinesi e raggiungibili, a volte, solo da strade
private, la cui costruzione implica ulteriori espropri. Questi nuovi
villaggi stanno progressivamente occupando, ad esempio, tutte le sommità
delle colline attorno a Betlemme e in generale sorgono ovunque;
all’interno di questi insediamenti si vedono spesso edifici vuoti, il che
fa supporre che lo scopo principale sia proprio prendere possesso dello
spazio, più che fornire nuovi spazi abitativi.
Oltre all’occupazione illegale del territorio, il muro (e con esso la
strategia degli insediamenti) sta provocando una vera e propria
ghettizzazione, per molti aspetti simile a quelle imposte dal nazismo agli
stessi ebrei o dal regime di apartheid del Sudafrica alla popolazione di
colore: l’esempio di Betania, villaggio vicino a Gerusalemme, che, come
altri, è stato letteralmente diviso in
 due a causa della costruzione del
muro in mezzo alle strade, ci ha ricordato il caso emblematico di
Varsavia, dove il quartiere ebraico venne separato dal resto della città.
Come ebrei e neri nel passato, i palestinesi stanno ora perdendo il
diritto alla liberta di movimento, essendo costretti a compiere deviazioni
lunghe e scomode per recarsi in posti fino a prima molto vicini o
vedendosi spesso negato l’accesso a determinati zone; di conseguenza
subiscono anche gravi limitazioni dei diritti alla salute, all’istruzione,
al lavoro e alla pratica religiosa, in quanto diventa sempre più
dispendioso e difficile (se non a volte addirittura impossibile)
raggiungere gli ambulatori o gli ospedali, le scuole e i luoghi di lavoro
o di culto. due a causa della costruzione del
muro in mezzo alle strade, ci ha ricordato il caso emblematico di
Varsavia, dove il quartiere ebraico venne separato dal resto della città.
Come ebrei e neri nel passato, i palestinesi stanno ora perdendo il
diritto alla liberta di movimento, essendo costretti a compiere deviazioni
lunghe e scomode per recarsi in posti fino a prima molto vicini o
vedendosi spesso negato l’accesso a determinati zone; di conseguenza
subiscono anche gravi limitazioni dei diritti alla salute, all’istruzione,
al lavoro e alla pratica religiosa, in quanto diventa sempre più
dispendioso e difficile (se non a volte addirittura impossibile)
raggiungere gli ambulatori o gli ospedali, le scuole e i luoghi di lavoro
o di culto.
Tutto ciò è dovuto non solo alla presenza del muro, ma anche al secondo
fattore determinante dello stato di occupazione in cui Israele tiene la
Palestina: i check-point (posti di blocco), insieme ai loro “cugini”, gli
sbarramenti. Noi stessi abbiamo avuto numerose esperienze all’ingresso di
città, villaggi e quartieri e se per noi è stato relativamente facile e
“indolore” passare (in quanto oltre a dover mostrare il passaporto ai
militari, a volte scendendo uno per uno dal pullman, o a dover aspettare
in coda per qualche tempo, non abbiamo subito altro) ci siamo resi conto
invece di cosa significhi per i palestinesi: perdono ore ed ore per i
controlli, che spesso diventano vere perquisizioni; in alcuni casi sono
costretti a cambiare mezzo di trasporto per proseguire oltre; sono fatti
passare in lunghe file attraverso corridoi costruiti da blocchi di cemento
e reti metalliche, come animali in gabbia, nessuno escluso, donne,
bambini, madri con lattanti, anziani…; è davvero una pratica umiliante,
soprattutto se si ricorda che la devono subire per muoversi all’interno
della propria terra! quanto oltre a dover mostrare il passaporto ai
militari, a volte scendendo uno per uno dal pullman, o a dover aspettare
in coda per qualche tempo, non abbiamo subito altro) ci siamo resi conto
invece di cosa significhi per i palestinesi: perdono ore ed ore per i
controlli, che spesso diventano vere perquisizioni; in alcuni casi sono
costretti a cambiare mezzo di trasporto per proseguire oltre; sono fatti
passare in lunghe file attraverso corridoi costruiti da blocchi di cemento
e reti metalliche, come animali in gabbia, nessuno escluso, donne,
bambini, madri con lattanti, anziani…; è davvero una pratica umiliante,
soprattutto se si ricorda che la devono subire per muoversi all’interno
della propria terra!
Per quanto riguarda gli
sbarramenti, abbiamo
trovato molte città (tra cui Nablus e Gerico) le cui vie d’accesso sono sbarrate da massi di cemento o
cumuli di pietre e così ridotte ad una sola, ovviamente controllata, e in
particolare abbiamo vissuto sulla nostra pelle la difficoltà di entrare in
queste città-prigione: volevamo visitare Hebron, ma abbiamo perso più di
un’ora e mezza per entrarci, visto che il primo tentativo è stato impedito
da una sbarra che chiudeva una strada, senza nessun militare presente per
poterla eventualmente aprire; il secondo da una striscia di macerie ben
disposta perpendicolarmente alla carreggiata, così da bloccare qualsiasi
automezzo; il terzo da una coppia di giovani soldati che ad un’altra
sbarra non hanno voluto ascoltare le richieste di un gruppo di pellegrini
alle tombe dei patriarchi (i due hanno anche avuto la gentilezza di
chiedere il permesso al superiore per telefono, ma senza ottenerlo); alla
fine abbiamo lasciato il pullman e attraverso stradine secondarie siamo
entrati a piedi…
La combinazione di muro e blocchi ha evidenti, gravi conseguenze sui
diritti vitali. L'accesso ai servizi sanitari, ad esempio: il
villaggio di Taybeh,
che fa riferimento all’ospedale di Ramallah, prima "distava"
13 km, ora ben 55! E nel corso del 2004 si sono verificate più di 60 nascite
proprio presso i check-point ( alcuni neonati sono stati chiamati Mashum, parola araba per “posto
di blocco”) ed anche oltre 20 casi di morte, tra mamme e bambini...
E nell'ambito dell'istruzione basti pensare alla abnorme esperienza
dei ragazzi palestinesi che per andare/tornare da scuola devono passare più volte per un check-point, dove
vengono controllato a fondo e quindi "etichettati" come un pericolo,
possibili terroristi, “cattivi” (e non si dice che i
bambini finiscono per diventare proprio come noi li facciamo sentire?). E
lungo la strada c'è sempre il rischio di incontrare qualche colono che ti
saluta con urla e botte o ti lancia insulti o, peggio, pietre...
Sul piano lavorativo, l’economia ridotta allo stremo dagli espropri e la
sempre maggiore difficoltà (o impossibilità) di raggiungere il posto di
lavoro o di effettuare spostamenti e trasporti commerciali provocano una
percentuale di disoccupazione attorno al 70%, tra le più alte al
mondo; un caso esemplare è quello di Qalqilia, paese a nord di Ramallah
ormai completamente circondato dal muro: gli abitanti sono costretti a
contare solo sulle scarse risorse a disposizione nel fazzoletto di terra
in cui vivono.
L’altra grande piaga della situazione palestinese che abbiamo potuto
toccare con mano sono i
campi profughi, allestiti dal 1948
 in avanti per
ospitare chi perse la casa durante le varie fasi della colonizzazione
israeliana. Inizialmente costituiti da tende fornite dalle Nazioni Unite o
dalla Croce Rossa, ora questi campi sono diventati piccole città con
edifici in muratura e basta visitarne uno, come quello
di Dheisheh, vicino a Betlemme, per rendersi conto di cosa voglia
dire vivere in uno dei luoghi più densamente popolati della terra: lì
abitano più di 11.000 persone in 1 kmq, senza spazi verdi né campi da
gioco, senza intimità di sorta, visto che la distanza tra una casa e
l’altra è quasi nulla, con un solo ambulatorio e un solo medico per tutti,
con una scuola che gli alunni frequentano a turno per mancanza di spazi
e sotto la costante preoccupazione dell'arrivo dell’esercito israeliano
(con bulldozer e bombe) per qualche demolizione a scopo punitivo. Quella avvenuta poco prima del nostro arrivo
aveva interessato
l’edificio destinato all’asilo, lasciando così 120 bambini senza un luogo
dove stare, una strada percorribile a proprio rischio e pericolo per la
caduta di macerie e 8 famiglie senza casa... in avanti per
ospitare chi perse la casa durante le varie fasi della colonizzazione
israeliana. Inizialmente costituiti da tende fornite dalle Nazioni Unite o
dalla Croce Rossa, ora questi campi sono diventati piccole città con
edifici in muratura e basta visitarne uno, come quello
di Dheisheh, vicino a Betlemme, per rendersi conto di cosa voglia
dire vivere in uno dei luoghi più densamente popolati della terra: lì
abitano più di 11.000 persone in 1 kmq, senza spazi verdi né campi da
gioco, senza intimità di sorta, visto che la distanza tra una casa e
l’altra è quasi nulla, con un solo ambulatorio e un solo medico per tutti,
con una scuola che gli alunni frequentano a turno per mancanza di spazi
e sotto la costante preoccupazione dell'arrivo dell’esercito israeliano
(con bulldozer e bombe) per qualche demolizione a scopo punitivo. Quella avvenuta poco prima del nostro arrivo
aveva interessato
l’edificio destinato all’asilo, lasciando così 120 bambini senza un luogo
dove stare, una strada percorribile a proprio rischio e pericolo per la
caduta di macerie e 8 famiglie senza casa...
In ultimo l'insopportabile senso di disagio che si
prova a vivere (per noi solo per pochi giorni, figuriamoci per una vita
intera!) in un’atmosfera angosciante come quella creata dall’elevata
militarizzazione della vita civile (città occupate come Hebron o la
stessa Gerusalemme brulicano di soldati che esibiscono le proprie armi) e
dal
clima di sospetto
che le autorità israeliane fanno pesare su palestinesi e stranieri, sia
nelle città, sia, soprattutto, negli aeroporti; qui la preoccupazione per
la sicurezza, fino ad un certo livello comprensibile, supera di gran lunga
tale livello, trasformandosi in una specie di volontà persecutoria
(gli
incaricati arrivano all’assurdo di controllare il materiale cartaceo dei
turisti e a indagare su eventuali contatti o conoscenze con i palestinesi)
e discriminatoria, visto che il fare inquisitorio è diretto soprattutto ai
soggetti in qualche modo assimilabili, per nome o fisionomia, al mondo
arabo. |
|
Dal nostro viaggio però non portiamo a casa solo impressioni
in negativo, ma
anche il ricordo di persone e realtà molto positive. Abbiamo
visitato i
laboratori di ceramica e i
frantoi della Olive Branch
Foundation di Taybeh-Ephraim (nonviolence@writeme.com) e il
centro per il
ricamo tradizionale della comunità melchita di Ramallah, due enti che
cercano di creare le basi per la pace dando una possibilità di lavoro e
guadagno alla popolazione locale.
Ad Ibillin, vicino a
 Nazareth, abbiamo avuto il privilegio di
incontrare
Abuna (Padre) Elias Chacour,
un sacerdote cristiano palestinese, candidato al Nobel per la pace
qualche anno fa, che ha dedicato la sua vita alla creazione di
un’istituzione educativa che accoglie per un ciclo di istruzione completo,
dall’asilo alle superiori (e da due anni anche fino all’università),
studenti di 4 religioni diverse, cristiani, ebrei, musulmani e drusi,
contribuendo così alla diffusione di una cultura di tolleranza,
riconciliazione e unità.
Un altro segno tangibile della possibilità di una convivenza pacifica tra
popoli diversi ci è stato offerto dal famoso
villaggio cooperativo Nevé
Shalom/Wahat al-Salam, il cui nome bilingue indica
con immediatezza come lì vivano famiglie ebree e palestinesi (attualmente
più di 50): queste organizzano insieme la vita della comunità e in particolare
la scuola bilingue-binazionale, aperta anche a centinaia di alunni da
molti villaggi vicini.
Infine vicino a Betlemme, a Beit-Sahour, si trova il
centro di
riabilitazione gestito dal YMCA,
i cui direttori, uno cristiano e uno musulmano, si occupano delle vittime del conflitto, curando la loro ripresa sia
fisica che psicologica nonché anche il loro reinserimento a livello sociale e
lavorativo... Nazareth, abbiamo avuto il privilegio di
incontrare
Abuna (Padre) Elias Chacour,
un sacerdote cristiano palestinese, candidato al Nobel per la pace
qualche anno fa, che ha dedicato la sua vita alla creazione di
un’istituzione educativa che accoglie per un ciclo di istruzione completo,
dall’asilo alle superiori (e da due anni anche fino all’università),
studenti di 4 religioni diverse, cristiani, ebrei, musulmani e drusi,
contribuendo così alla diffusione di una cultura di tolleranza,
riconciliazione e unità.
Un altro segno tangibile della possibilità di una convivenza pacifica tra
popoli diversi ci è stato offerto dal famoso
villaggio cooperativo Nevé
Shalom/Wahat al-Salam, il cui nome bilingue indica
con immediatezza come lì vivano famiglie ebree e palestinesi (attualmente
più di 50): queste organizzano insieme la vita della comunità e in particolare
la scuola bilingue-binazionale, aperta anche a centinaia di alunni da
molti villaggi vicini.
Infine vicino a Betlemme, a Beit-Sahour, si trova il
centro di
riabilitazione gestito dal YMCA,
i cui direttori, uno cristiano e uno musulmano, si occupano delle vittime del conflitto, curando la loro ripresa sia
fisica che psicologica nonché anche il loro reinserimento a livello sociale e
lavorativo...
|

Da dicembre viaggio ad oggi sono accaduti eventi importanti, a cominciare
dalle elezioni presidenziali dell’Autorità Palestinese, che hanno
dimostrato la maturità, lo spirito democratico e la volontà di
crescita libera e indipendente di quel popolo; ma soprattutto hanno
finalmente avuto luogo i colloqui di Sharm El Sheik e l’occidente si
è di nuovo impegnato nella questione. Di conseguenza, alcune città
palestinesi sono state riconsegnate all’AP: questo significa che gli
edifici occupati dall’esercito israeliano che abbiamo visto a
Betlemme probabilmente ora sono stati abbandonati, e, come le
immagini televisive ci mostrano, la città di Gerico non è più
circondata da blocchi di cemento e postazioni militari…
Questi però sono solo piccoli passi. Passi sicuramente notevoli e
portatori di speranza, ma ancora piccoli: rimangono quelle centinaia
di km di vergogna, quel muro che continua ad avanzare (nonostante
sia stato dichiarato illegale dal Tribunale Internazionale dell’Aja
ancora a luglio 2004), quel pullulare di check-point e tanti altri
pesanti elementi che non possono non essere definiti "di
occupazione".In fondo nessun nuovo piano di pace completo, che
cerchi di risolvere tutti i nodi della questione, tra cui il dramma
dei profughi, è stato messo in piedi; e se si sta preparando il
tanto proclamato ritiro da Gaza, le colonie nel West Bank (la
Cisgiordania) continuano ancora moltiplicarsi sull'esempio di come
abbiamo potuto
vedere con i nostri occhi a dicembre.
Diario di amarezza, diario di speranza. |
|
|
|