|
|
|
L'ultimo
lavoro di Leonardo Rampazzi è il volume Locus Fictus (casa
editrice - Il Prato) in cui "viene analizzata l’opera d’arte
pittorica nella sua molteplicità di aspetti, rivelando cosa si
nasconde dietro la semplice osservazione di un quadro e, con esempi e
riferimenti mirati, costruendo un percorso fatto di constatazioni
visive oggettive e di sensazioni soggettive che ogni individuo compie,
inconsciamente, ponendosi a confronto con un dipinto. Il quadro viene
visto come scena, come teatro in cui ogni spettatore dell’opera occupa
un posto privilegiato…" |
|
|
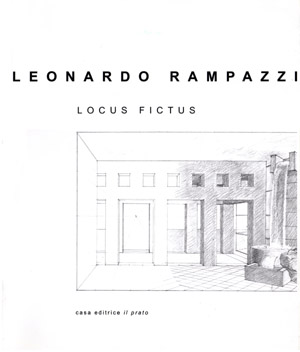
Introduzione
A partire
dall’Umanesimo, la scena e la scenografia costituiscono per lungo
tempo un terreno favorevole alle esibizioni della prospettiva: non
diversamente dalla pittura. “Nelle sue applicazioni sceniche, la
prospettiva delimita uno spazio in cui il punto di vista viene
stabilito nella loggia del principe e il punto di fuga, diametralmente
opposto, al centro della pittura del fondale.” Questo spazio
costituisce già di per sé un luogo teatrale, che è lo stesso luogo
‘teatrale’ istituito dalle relazioni tra la pittura prospettica e i
suoi osservatori. Se nel luogo che si specifica come ‘teatro di corte’
l’unico punto di osservazione ‘legittimo’ è appunto quello situato
nella loggia del principe (tanto che agli altri, i cortigiani, è in
fondo concesso sol tanto di assistere allo spettacolo del pieno
godimento principesco della scena, privilegio dal quale sono di fatto
esclusi), nel ‘teatro’ della pittura prospettica la ‘loggia del principe’ è accessibile a chiunque, vale a dire che in esso il punto
di vista, di volta in volta vacante, conferisce a chi lo occupa almeno
la sovranità di uno sguardo ‘legittimo’. Questa sovranità
dell’osservatore allorché occupa e
 detiene il punto di vista, è
finalmente resa esplicita da un quadro come Las Meninas, dove egli
viene identificato con il Re e la Regina, ciò che spiega perché tanti
occhi di cortigiani, compresi quelli del pittore di corte, gli si
stiano rivolgendo direttamente. Ci viene svelato, tra l’altro, il
segreto di questo ‘teatro’, non tanto ‘di corte’, quanto
identificabile con la ‘corte’ stessa: la reversibilità e la
specularità di spettatore e spettacolo. detiene il punto di vista, è
finalmente resa esplicita da un quadro come Las Meninas, dove egli
viene identificato con il Re e la Regina, ciò che spiega perché tanti
occhi di cortigiani, compresi quelli del pittore di corte, gli si
stiano rivolgendo direttamente. Ci viene svelato, tra l’altro, il
segreto di questo ‘teatro’, non tanto ‘di corte’, quanto
identificabile con la ‘corte’ stessa: la reversibilità e la
specularità di spettatore e spettacolo.
È a partire da queste considerazioni che sono stato indotto a
rileggere certe opere di pittura, di cui non voglio qui avanzare
giudizi sulla peculiare qualità pittorica, dei cui autori nell’ambito
della storia dell’arte non mi compete qui di parlare, ma che mi
colpiscono nella loro qualità insieme di finzione e di progetto di
luoghi e di tempi e che mi impongono, lo ripeto, un’esperienza analoga
a quella teatrale. Sono stato innanzitutto attirato da un aspetto
squisitamente professionale nell’operazione che vede i pittori, autori
ditali opere, intenti ad allestire scene che, nel fingere aspetti del
mondo reale, li compongono in modo da illudere il nostro sguardo di
essere il sovrano - ma direi anche l’artefice, il dio creatore - di un
mondo analogo e sostitu tivo: il quale cioè, nel rappresentarlo si
sostituisce al mondo reale punto per punto, costituendosi di nuovo e
analogamente di cieli, di nuvole, di acque, di alberi, di edifici, di
stanze, di oggetti, di animali, di figure umane..., conservando
tuttavia la pro pria autonoma esistenza alla fissità nella
collocazione del proprio sovrano o creatore, lo sguardo.
Considero degno di nota, prima di tutto, il fatto che il pittore,
componendo la scena, componga allo stesso tempo un mondo, particolare
e particolareggiato fra tutti quelli rappresentativi del mondo reale,
avendo dovuto compiere una selezione ‘d’individui’ delegati a
rappresentare i generi, le specie, le categorie che lo articolano; poi
che lo presenti in modo da denunciare di dove proviene lo sguardo che
ne è, in un certo senso, il ‘motore immobile’, rimandando cioè a una
postazione inamovibile, centro di emanazione e insieme obiettivo di
tutte le operazioni che lo costituiscono (pensiamo ancora alla loggia
del principe); infine, di conseguenza, che ce lo presenti come una
soggettiva del suo immobile ‘creatore’, rivelando che la finzione di
oggettività è tributaria del particolare punto dello spazio in cui,
per l’occasione, egli è andato ad immobilizzarsi. In rapporto a quest’ultima
considerazione, si può sostenere che quella soggettiva ci rende
visibile soltanto un frammento di un mondo che tuttavia possiamo
immaginare esteso all’infinito, in un infinito fuori-campo.
Perché non si tratta qui genericamente di pittura o di scena teatrale
ma più esattamente di quadro (il quadro prospettico), sia esso
delimitato da una cornice, da un boccascena, o da un formato standard.
Il quadro diviene, osserva appunto Panofsky, “frammento della realtà,
nella misura e nel senso che lo spazio immaginato procede ormai in
tutte le direzioni oltre quello raffigurato; e così proprio la
finitezza del quadro fa avvertire l’infinità e la continuità dello
spazio.”
Ciò è proprio di ogni opera della pittura prospettica in quanto quadro
nel dispositivo sopra descritto. È qualcosa di legato al funzionamento
della prospettiva e che è passato anche all’azione in movimento
(cinematografica e televisiva) nella misura in cui questa è vincolata
al formato fisso di ogni inquadratura e alla posizione (solo una alla
volta) via via assunta dalla macchina da ripresa.
Leonardo Rampazzi
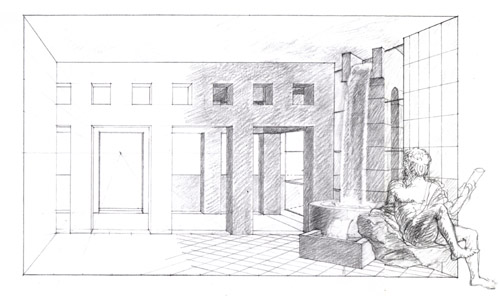 |
|
|
|
|
Sia
alla prima lettura sia in quelle successive, Locus fictus
ha continuato ad evocarmi
L’arca
russa (il film di Sokurof), a mano a mano ho cominciato a
mettere a fuoco che anche nel libro un visitatore invisibile
attraversa in soggettiva vani e porte, soglie e pareti senza
stacchi, come in un lungo piano/sequenza. Un visitatore
invisibile che ci accompagna con prodigiosi movimenti di
macchina nelle stanze (non solo metaforiche) della pittura,
attraverso schermi e cornici, finestre e specchi, avanti ed
indietro nel tempo, ad incrociare scene, sguardi, fasci di luce
ed ombre, allungate per meglio evocare il fuori campo, quel
rovescio della medaglia che continua ad interrogarci.
Io credo che la vocazione sottesa a questo testo o, se volete,
il talento ulteriore che ne emerge, abbia a che fare con la
scrittura cinematografica, o meglio, col trattamento, quella
scrittura del film appena precedente la sceneggiatura vera e
propria. In fondo, cos’è per un film il trattamento e/o la
sceneggiatura se non la rappresentazione (in questo caso
linguistica) che precede la rappresentazione visiva? Un modello
verbale che simula e prefigura quello visivo, l’allestimento di
una rappresentazione che precede la vera rappresentazione.
Giusto per utilizzare concetti e terminologie cari a Leonardo
Rampazzi.
A lui, però, non interessa immaginare e costruire nuove
rappresentazioni, non interessa inventare storie, lui è
interessato a re-immaginare, a ri-mettere in scena
rappresentazioni già esistenti, a lui piace trattare e rimontare
rappresentazioni ampiamente frequentate e codificate, per
schiuderle a nuove letture, per rivelarne un supplemento di
senso. Il tutto con una scrittura che sembra mutuata più dalle
frequentazioni cinematografiche che dai testi di storia
dell’arte. Dico questo non perché nel libro troverete citazioni
di film, ma perché qui le opere pittoriche sono raccolte e messe
in sequenza, attraversate e narrate con tecnica cinematografica.
A cavallo di un dolly passerete attraverso le finestre di
Magritte, per imbattervi nella Fresh Widow di Duchamp,
dall’alto vi calerete nelle Room di Hopper per passare
poi a curiosare, rasoterra, nell’Interno con donna di De Witte e
fare un po’ capolino nello specchio che Vermeer ha messo di
fronte alla donna de La collana di perle.
In questo libro Leonardo Rampazzi crea sull’immagine fissa della
pittura una specie di trattamento in post-produzione, potrebbe
sembrare una contraddizione in termini, ma solo un ossimoro può
restituirne la peculiarità: creare un movimento nel fermo
immagine della pittura. Movimento che non è indotto, però, dallo
scorrere delle immagini: quadri, incisioni ed affreschi sono, in
questo testo, animati dal movimento del pensiero, un pensiero
appassionato (prima ancora che cristallino), che in certi
passaggi sembra abitare fisicamente gli spazi osservati, gli
schermi interpretati.
Non vi accorgerete che state semplicemente leggendo della
Fanciulla che dorme di Vermeer, e in punta di piedi, non
senza suspence, avrete già varcato la soglia; con occhio
indiscreto, stando attenti a non sbattere contro le
suppellettili che ingombrano il proscenio, state cercando di
vedere cosa c’è dietro nell’altra stanza, per scoprire
“ciò che viene celato e sottratto allo sguardo, da quello stesso
che si fa avanti per rendersi visibile” [...] “realizzando
quello stravolgimento dell’aspetto familiare delle cose (delle
opere nella fattispecie) nello stesso momento in cui,
esplicitamente, gli si richiede di farcele riconoscere”.
Dopo aver letto questo libro, provate a pensare cosa sarebbe
una mostra costruita con un progetto simile, provate a sognare
un museo o meglio dei musei (magari anche solo virtuali) in cui
la sovrabbondanza di materiali, l’accumulo di rappresentazioni,
spesso pletoriche, venga sfrondata ed offerta in sequenze
autosignificative, come collane di perle tenute insieme dal filo
di un pensiero lucido, appassionato ed appassionante come quello
di Leonardo Rampazzi...
Antonio De Pascale
(presentazione del volume al Liceo Modigliani - 2 novembre 2005) |
|
|