|
Un
medico deve scoprire, parallelamente alle indagini della polizia su
un efferato delitto, quale di due sorelle gemelle è una psicopatica
assassina. È un piccolo classico del
noir degli anni '40. Partendo
da una solida e aguzza sceneggiatura di Nunnally Johnson, da un soggetto
di Vladimir Pozner, R. Siodmak lavora bene di chiaroscuro. Esercizio
di bravura di O. de Havilland in 2 parti "speculari".
|
|
Lo specchio
scuro narra di due gemelle, l'una normale e l'altra folle, una delle quali
ha commesso un assassinio (la seconda, naturalmente, che però maschera la
sua follia dietro perfette apparenze di normalità). Nessuno può dire quale
delle due sia la colpevole poiché fra esse vige un'assoluta solidarietà e
soprattutto perché l'innocente crede che l'altra non sia colpevole. In due
scene chiave le gemelle sono mostrate ambedue riflesse in uno specchio.
Nella prima la gemella A (colpevole) è inquadrata fuori e dentro lo
specchio, mentre la B (innocente) è semplicemente riflessa, poiché la sua
immagine reale è fuori campo. Nella seconda scena avviene l'inverso: la B è seduta di fronte allo specchio e
ne viene riflessa mentre la A è solo riflessa mentre è in piedi fuori
campo vicino all'altra. L'occhio dello spettatore, già perplesso di fronte
alla costante presenza del tema del "doppel" nel film, ne esce qui
addirittura confuso: la sensazione è che ormai non importi più chi delle
due è la folle e l'assassina poiché la somiglianza uguaglia la forma e la
materia. Si tratta di una perfetta esemplificazione delle affermazioni di
Freud in merito al tema del "doppel" in relazione al concetto di
"perturbante" Ma soprattutto l'occhio coglie un complesso intrecciarsi di
sguardi che non restano relegati nel campo dello specchio, e nemmeno in
quello della macchina da presa, ma che penetrano lo schermo all'inverso,
attraverso un campo che si pensava inviolabile, divenendo l'occhio
dell'occhio spettatoriale. L'implicita domanda che tale sistema di sguardi
pone è: chi guarda chi? E ancor più: in questo intrecciarsi di
osservazioni il cui soggetto sfugge continuamente alla stessa stregua del
loro oggetto, il vero osservato, non è in realtà colui che crede di essere
l'esclusivo osservatore, cioè lo spettatore? Qualcuno obietterà che Lo
specchio scuro non è un film dell'orrore. Ciò è vero nel senso che in esso
non intervengono componenti di carattere soprannaturale. Ma almeno da
Henry James in poi sappiamo bene che l'orrore non è la conseguenza
dell'osservazione dell'inspiegabile in termini razionali, bensì
l'oscillazione fra tale possibilità e quella, antitetica, di una realtà
che sembra non reale. In una parola, l'orrore è l'incertezza sull'orrore.
Un passo in più e un'opera come quella di Siodmak giunge a dirci che
l'orrore, nella miglior linea freudiana, è il perturbante (salve restando
le osservazioni fatte da Freud in apertura al suo famoso e splendido
saggio Il perturbante del 1919): non lo schifo, il disgusto, la repulsione
davanti all'anomalo, ma la scoperta, la sensazione della "non-familiarità"
che scopriamo in noi davanti alla stessa normalità. E dunque, che tutto il
cinema sia soltanto cinema dell'orrore (o del perturbante)? Che tutto il
cinema, cioè, instauri a livello psichico — e sia pure in diversa misura —
la sensazione dell'"Unheimlich" freudiano?
seconda scena avviene l'inverso: la B è seduta di fronte allo specchio e
ne viene riflessa mentre la A è solo riflessa mentre è in piedi fuori
campo vicino all'altra. L'occhio dello spettatore, già perplesso di fronte
alla costante presenza del tema del "doppel" nel film, ne esce qui
addirittura confuso: la sensazione è che ormai non importi più chi delle
due è la folle e l'assassina poiché la somiglianza uguaglia la forma e la
materia. Si tratta di una perfetta esemplificazione delle affermazioni di
Freud in merito al tema del "doppel" in relazione al concetto di
"perturbante" Ma soprattutto l'occhio coglie un complesso intrecciarsi di
sguardi che non restano relegati nel campo dello specchio, e nemmeno in
quello della macchina da presa, ma che penetrano lo schermo all'inverso,
attraverso un campo che si pensava inviolabile, divenendo l'occhio
dell'occhio spettatoriale. L'implicita domanda che tale sistema di sguardi
pone è: chi guarda chi? E ancor più: in questo intrecciarsi di
osservazioni il cui soggetto sfugge continuamente alla stessa stregua del
loro oggetto, il vero osservato, non è in realtà colui che crede di essere
l'esclusivo osservatore, cioè lo spettatore? Qualcuno obietterà che Lo
specchio scuro non è un film dell'orrore. Ciò è vero nel senso che in esso
non intervengono componenti di carattere soprannaturale. Ma almeno da
Henry James in poi sappiamo bene che l'orrore non è la conseguenza
dell'osservazione dell'inspiegabile in termini razionali, bensì
l'oscillazione fra tale possibilità e quella, antitetica, di una realtà
che sembra non reale. In una parola, l'orrore è l'incertezza sull'orrore.
Un passo in più e un'opera come quella di Siodmak giunge a dirci che
l'orrore, nella miglior linea freudiana, è il perturbante (salve restando
le osservazioni fatte da Freud in apertura al suo famoso e splendido
saggio Il perturbante del 1919): non lo schifo, il disgusto, la repulsione
davanti all'anomalo, ma la scoperta, la sensazione della "non-familiarità"
che scopriamo in noi davanti alla stessa normalità. E dunque, che tutto il
cinema sia soltanto cinema dell'orrore (o del perturbante)? Che tutto il
cinema, cioè, instauri a livello psichico — e sia pure in diversa misura —
la sensazione dell'"Unheimlich" freudiano? |
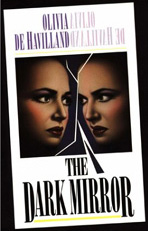

![]() AMICHE? RIVALI? CERTO SORELLE
- ottobre-dicembre 2009
AMICHE? RIVALI? CERTO SORELLE
- ottobre-dicembre 2009