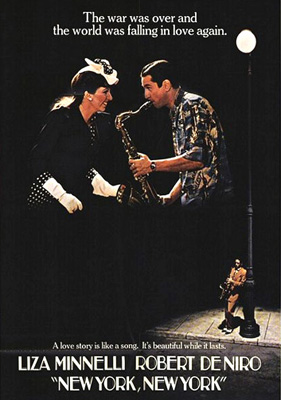Martin
Scorsese, acclamato autore di
Taxi Driver,
ha rischiato grosso con questo suo
New York, New York,
un non-musical che poco concede al pubblico, pure tra gli apparenti fumi
commerciali dell’impostazione musicale, ma che supera l’inghippo della
monotonia con un gioco di espressività e ponderazione che avvince e
aggiunge credibilità al discorso critico delle opere precedenti.
Il film si apre con le celebrazioni americane del 2 settembre 1945, il
giorno della vittoria; una camicia militare buttata, le scarpe bicolori
del protagonista, la sua pacchiana maglietta “hawayana” sono simboli
dell’euforia sociale del momento e l’agitarsi della folla esultante, il
turbinio dei coriandoli che invadono New York monopolizzano a poco a
poco la nostra attenzione, ci fanno entrare nell’atmosfera e ci rendono
partecipi della gioia collettiva di un salone in festa. Tutto è
grandioso, "americano". La grande pista da ballo è affollatissima e, su
un palco, una tipica orchestra jazz tiene banco: musicisti impeccabili,
tutti seduti al loro posto, ottoni luccicanti, calibratissime esecuzioni
stile Glenn Miller. Sono tasselli fondamentali per la comprensione del
momento storico e, nelle trombe dirompenti, nel loro brillare nella
grande sala, vive tutta l’esaltazione di un popolo tornato finalmente in
pace, tornato vincitore e più che mai sicuro di sé.
Il De Niro, che entra baldanzoso con la sua “divisa” da cafone, ne è un
altro simbolo, è lo stereotipo dell’americano, ebbro di felicità, con il
solo problema di una ragazza per la notte; la malcapitata a cui alla
fine sciorina la sua sfacciata galanteria è un’ausiliaria (Liza Minelli),
non troppo carina né troppo fortunata visto che, dopo un’inutile
resistenza, dovrà cedere all’invadenza del suo futuro compagno di vita.
È il momento più spassoso della pellicola, con un De Niro in gran forma
(forse fin troppo gigione), e tutto rimane sulla farsa finché lui, Jimmy
Doyle, saxofonista in cerca di lavoro, non si presenta ad una prima
audizione. D’improvviso Scorsese cambia marcia: il sax trascinante del
protagonista, l’entrata di lei che lo accompagna al canto ci trasportano
in una dimensione nuova, in un mondo diverso dove Jimmy e Francine sono
realmente se stessi, due musicisti di gran talento che vedono nel loro
lavoro non solo un mestiere, ma una ragione di vita.
Così il film parte al seguito dei loro impegni orchestrali, vive dello
swing degli anni, della loro maturazione artistica, della loro creativa
intesa; ne analizza il crescente successo, entra con loro nell’autobus
che li trasporta in tournee per gli States. Non è più il Jimmy
strafottente, è scomparsa la Francine scontrosa dei primi approcci, i
due vivono ora di musica e di essa si avvolgono il film e lo spettatore.
Le sequenze al di fuori del loro vivere scenico (l’iniziale
chiacchierata in auto con un fotomontaggio che mostra l’azione fuori dai
finestrini, l’incontro invernale in cui il paesaggio con la neve e gli
alberi altro non è che un fondale di teatro) stridono volutamente nel
contesto, sono estranee ad un’opera che non è un musical, ma che
racconta con la musica l’essere di due persone, il crescere di una
nazione che dà spettacolo, ma che traballa al di fuori di esso. La
nascita di un figlio, un fatto concreto, umano metterà infatti in crisi
la loro unione di coppia e mentre lei accetterà il suo nuovo ruolo di
madre lui vedrà in quella panciona un ostacolo alla loro carriera, in
quel neonato un impegno sociale troppo grosso e si allontanerà
definitivamente dalla compagna.
Li ritroviamo diversi anni dopo, entrambi resi più adulti dagli
inebrianti successi personali ma non abbastanza da rimettersi insieme:
sarà Francine a non accettare l’invito, troppo poco sicura della
maturità di Jimmy e forse anche della propria.
Un finale triste quindi per un film che è un crescendo di amarezza ed
inquietudine e che, mentre rievoca qua e là il boom di
Cantando sotto la
pioggia, fa da simbolo ad un’epoca sempre
in bilico, come lo spettacolo, tra la freschezza del tip-tap e la
solitudine notturna di un lampione. Si può trovare forse un’affinità col
Come eravamo di Pollack, ma se lì a prevalere era l’aspetto romantico,
che si intesseva e si disfaceva nella partecipazione del momento
sociale, qui De Niro e la Minnelli, pur nella loro eccezionale
interpretazione (specie lei che ha dalla sua delle partiture di alto
livello), vivono al di fuori dei fatti sociali e restano dei comprimari
perché il vero primo attore è la musica, attraverso la quale
Scorsese
spiega gli umori dei suoi personaggi e di tutta l’America.
Del parallelo iniziale tra stato d’animo e orchestra già abbiamo detto,
ma tutta l’opera gioca su questo binomio: così, quando i due crescono
come artisti e la nazione cerca maturazione, anche la musica si fa più
curata ed avanguardistica e quando insieme raggiungono il successo, i
loro brani sono tra i più noti e belli del dopoguerra; il loro momento
d’amore-crisi lievita sugli accordi di un pianoforte e l’isolamento di Jimmy si affianca a quello del jazz che, nei locali
dei neri, riscopre la
sua anima ed il suo swing.
E proprio nel finale, mentre Doyle anche se famoso rimane un
“emarginato” col suo suono d’elite, il regista scruta, forse con velato
rammarico, l’imbellettato Happy Endings di Francine Evans la quale (dopo l’evocativo momento della registrazione in studio) entra nelle
spire di una canzone di spettacolo che dà l’interprete in pasto al
pubblico, che guarda più all’efficacia dell’interpretazione e all’eterno
scintillare degli strumenti che all’intimismo delle musiche, che
affascina “attori e spettatori” tradendo il purismo del jazz e la
crescita artistica e sociale di un popolo alle soglie di una crisi di
identità.
|
fotografia: Laszlo Kovacs - scenografia: Boris Leven -
musica: John Kander e Fred Ebb |
|
ezio leoni
(1997) |