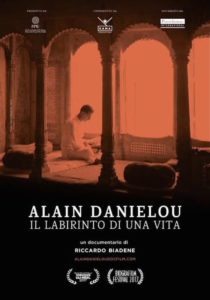Un film documentario su una delle figure più importanti e sottovalutate nella storia moderna delle relazioni tra India e Occidente. Alain Daniélou – Il labirinto di una vita, narra dell’originale esistenza e delle scoperte di un artista, traduttore e studioso francese che giunse in India la prima volta via nave nel 1932 per rubarne con successo l’essenza spirituale, prima di trasferirsi in Italia a due passi da Roma, nello splendido borgo di Zagarolo, in una località chiamata già anticamente Il Labirinto. La ricostruzione con cui Riccardo Biadene gli rende omaggio è un viaggio nel labirinto esistenziale di quest’uomo controverso e straordinario: ci accompagna per mano attraverso uno dei più prolifici periodi di incontro tra culture dell’era moderna. Un viaggio fisico, musicale e mentale che dovrebbe percorrere chiunque voglia comprendere – piaccia o non piaccia – la fascinazione occidentale per l’India che dura fino ai giorni nostri.

Italia 2017 – 1h 18′
La storia di Danielou, scomparso negli anni ’90, è raccontata dal regista Riccardo Biadene con i tempi di un lento raga e i colori ocra dei templi hindu, ricco di una seria ricostruzione storica, interviste e testimonianze, dagli anni di “iniziazione” mistica dell’ex danzatore – “scomunicato” dalla famiglia perché gay – alla sua amicizia con il Nobel Tagore al quale presento’ Andrè Gide, agli ashram dei suoi guru che lo sottoponevano a severe penitenze per trasmettergli “da bocca vecchia a orecchio giovane” i segreti della propria musica e della spiritualità vedica. La lentezza del film è forse indispensabile per imprimere nella memoria passaggi di una storia complessa, un vero labirinto di incontri, di eventi memorabili, sogni e delusioni che riemergono assieme all’essenza del messaggio di questo grande studioso anomalo, che è stato a lungo contestato anche dopo il suo best seller Miti e dèi dell’India perché non era un accademico. Ma da audidatta Danielou riuscì laddove nessuno aveva ancora osato tentare, creare un ponte solido tra culture fino a quel momento semi sconosciute l’una per l’altra. Non solo Gide ma Renoir, il coreografo Bejart e numerosi artisti dopo di loro – Philip Glass, Steve Reich, gli stessi Beatles – hanno beneficiato dell’impegno di Danielou per offrire al suo occidente qualche perla tra quelle da lui scoperte 80 anni fa lungo le rive del Gange e dell’Oceano, ai piedi di saggi delle foreste e in città sacre e immortali come Benares, dove la residenza di Danielou e del suo compagno Raymond divenne punto di riferimento per decine di artisti e monaci erranti sadhu. Perfino Indira Gandhi gli scrisse una lettera dove sottolineava il suo ruolo unico nel divulgare l’arte indiana nel mondo.
Già negli anni ’60 a Berlino e Venezia, dove la Fondazione Cini ospito’ l’Istituto a suo nome, Danielou fece conoscere grandi artisti della scena classica indiana, tentando sempre di creare per loro un diaframma di protezione dalle contaminazioni, dai “modernismi” che presto ebbero pero’ la meglio anche sull’opera di alcuni mostri sacri di quella musica. Fu il caso del sitarista Ravi Shankar che deluse Danielou fin dai suoi primi concerti assieme al celebre Yehudi Menuhin. Il successo di pubblico di quei loro duetti violino-sitar fu l’inizio della fama di Shankar e del boom di arrivi di artisti indiani in Occidente, ma anche la fase di avvio di esperimenti di fusion che l’artista francese riteneva “abominevoli”. Lui che aveva passato sei anni a studiare senza pause con un maestro di sitar a Benares prima di fuggire dal suo eremo di sola musica e miti. La ricostruzione di Riccardo Biadene gli rende omaggio con perdonabili lacune su tutta l’attività letteraria e antropologica di Danielou, dagli studi sui testi antichi alle ricerche di leggende degli antichi popoli originari del grande Continente. Ma il viaggio del film nel labirinto esistenziale di quest’uomo controverso e straordinario, ci accompagna per mano attraverso uno dei più prolifici periodi di incontro tra culture dell’era moderna. Un viaggio fisico, musicale e mentale che dovrebbe percorrere chiunque voglia comprendere – piaccia o non piaccia – la fascinazione occidentale per l’India che dura fino ai giorni nostri.
Raimondo Bultrini – repubblica.it


India anni Trenta. Due uomini occidentali, fidanzati, in giro per terre sconosciute in roulotte. Non si tratta di antesignani fricchettoni alla scoperta di se stessi nel misticismo indiano, bensì di Alain Daniélou e Raymond Burnier, un danzatore musicista francese di origini altolocate (padre ministro socialista e fratello cardinale) e un fotografo appassionato di arte indiana. Finiscono nell’ashram in Bengala di Rabindranath Tagore, scrittore premio Nobel che lì aveva fondato una scuola, si innamorano della pace del luogo e degli insegnamenti del maestro, si stabiliscono per un periodo. Successivamente si trasferiscono sulle rive del Gange, fiume sacro all’induismo, dove vivono nel palazzo di Rewa per quasi 20 anni. Durante il soggiorno indiano Daniélou studia il sanscrito, i testi vedici, la filosofia, la musica e la danza indiane, alla ricerca di un’armonia fra natura e spirito. L’occidente gli andava stretto (come forse lui all’occidente), ci si sentiva fuori posto: l’India gli permette la ricerca interiore di cui ha bisogno. Nella casa sul fiume riceve visite di personalità indiane e occidentali: Jawaharlal Nehru, Jean Renoir (durante le riprese di The River), Cecil Beaton, Eleanor Roosvelt, Roberto Rossellini. È la visione complessa e articolata della metodologia di Daniélou, illuminato musicologo con l’attitudine a far circolare la bellezza nel mondo (a lui si devono le registrazioni dei canti tribali delle popolazioni orientali mai ascoltate prima fuori dai loro paesi d’origine: dal 1950 Daniélou diventa curatore della prima collezione mondiale di musica etnica classica per l’Unesco), che viene raccontata nel complesso e bel documentario di Riccardo Biadene, Alain Daniélou: il labirinto di una vita. Tornando sui passi del grande uomo, Biadene si reca in India, a Varanasi, a Pondicherry, a casa Tagore, a Berlino all’Istituto di Musica Comparata, a Zagarolo, vicino Roma, dove Daniélou, nel 1980, decise di spendere gli ultimi anni della sua vita in una villa labirinto (sede anche della fondazione Harsharan, ora India Europa di Nuovi Dialoghi, fondata nel 1968 dopo la morte del suo compagno Raymond Burnier). Un materiale denso e ricchissimo di interventi, dalla nipote all’ultimo compagno di vita, ai collaboratori, a danzatori e musicisti indiani, a studiosi di etno-musicologia, cinquantasei persone in tutto, raccontano l’uomo unico e di genio. Il flusso narrativo è travolgente, le foto, le statue erotiche dei templi indù, il Gange, l’umanità speciale, il senso di un tempo che non c’è più, la magia delle prime volte, tutto questo sommerge e disarma da resistenze western lo spettatore, coinvolto in prima persona in una immersione da capogiro nel labirinto di una vita (titolo dell’auto-biografia di Alain Daniélou). L’intenzionale volontà registica di incuriosire e appassionare ad una materia poco conosciuta colpisce nel segno: si esce dalla sala col desiderio ardente di ascoltare dal vivo degli interminabili e ipnotici raga di musica classica indiana o di vedere le espressioni eccessiva, codificate formalmente in mudra, di una ballerina di danza Bharata Natyam. Desiderio, ahi noi, assai difficile da esaudire.
Fabiana Sargentini – close-up.it