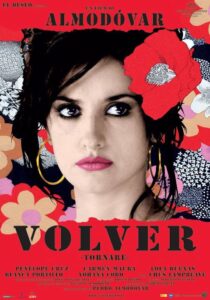USA 2022 (167′)
 VENEZIA – Che Andrew Dominik sia un grande ripercorritore di opere-e-momenti chiave della storia del cinema non lo scopriamo oggi. Era già evidente nella rarefazione delle atmosfere in incipit di quello che è, forse, il suo risultato più alto: L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. In quella osmosi tra personaggi e scenari naturali indotta per sola via di stile il debito malickiano era dichiarato senza reticenze, in maniera semplice e piana.a.
VENEZIA – Che Andrew Dominik sia un grande ripercorritore di opere-e-momenti chiave della storia del cinema non lo scopriamo oggi. Era già evidente nella rarefazione delle atmosfere in incipit di quello che è, forse, il suo risultato più alto: L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. In quella osmosi tra personaggi e scenari naturali indotta per sola via di stile il debito malickiano era dichiarato senza reticenze, in maniera semplice e piana.a.

I campi di grano e le scene al crepuscolo de I giorni del cielo (1978), la voce fuoricampo, l’arrotarsi degli arpeggi di Nick Cave in una rielaborazione a mezzo tra l’omaggio e la gentile parodia delle Gymnopédies di Erik Satie, che col suo Trois morceaux en forme de poire faceva capolino tra le musiche de La rabbia giovane (1973). Di tanto assorto stupore malickiano il cineasta neozelandese dava una rilettura che non stenteremmo a definire paranoica, nella misura in cui esaltava per ossimoro le psicologie inquiete e sbilenche dei personaggi e le brutali esplosioni di violenza, secondo una prassi tipicamente postmoderna. A distanza di quindici anni da quel vertice e a dieci dal suo precedente film di finzione Cogan – Killing Them Softly (nel mezzo ben due documentari dedicati al sodale Nick Cave), Dominik torna a meditare sulla celebrità come aberrazione, partendo dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates dedicato all’icona pop per eccellenza e impiegando, di nuovo, la lente deformante della storia del cinema. Se in precedenza era stato Malick a veder saccheggiato, esaltato, riletto, sformato il proprio stile, qui lo sguardo è informato da un altro grande centro del cinema contemporaneo, quel David Lynch che, silenziosamente defilatosi dagli oneri del grande schermo da ormai quasi vent’anni (con l’eccezione della maestosa terza stagione del serial Twin Peak) ha saputo, alla svolta del nuovo millennio, marchiare a fuoco la coscienza del pubblico e dei cineasti a venire con un uno-due di sfrontata singolarità. Mulholland Drive (2001) e INLAND EMPIRE (2006) si pongono come i centri di gravità di un nuovo modo di concepire la natura sensoriale della messa in scena e le possibilità di frammentazione del racconto ed è attraverso la novità delle forme e la potenza inquieta del loro stile che Dominik inquadra la vita e la morte della triste Norma Jeane, in arte Marilyn Monroe.
Ecco allora in incipit un momento d’infanzia che ha già il sapore dell’incubo. Poi l’orfanotrofio, la carriera di modella, il cinema, i produttori, le avances subito voltate in disgustose, persistenti violenze, un ménage à trois (dalle terribili ricadute) coi figli di Charlie Chaplin e Edward G. Robinson. E ancora gli aborti, i matrimoni, l’iconico momento di Quando la moglie è in vacanza (1955), il rapporto con Arthur Miller, il teatro, le droghe. E John F. Kennedy, ovviamente. Sebbene da queste poche righe si sia tentati di definirla l’esaustivo resoconto di una vita tormentata in cui i momenti storicamente rilevanti siano, bene o male, tutti presenti, la sceneggiatura di Dominik dà più l’idea di voler organizzare il racconto attorno a uno sgradevole rosario di crudeltà perpetuate ai danni della protagonista. In ciò si è ravvisato un limite del progetto, al punto che da più parti sono piovute sul film accuse di parzialità, se non di aperto travisamento della figura dell’attrice. Come a dire che Marilyn Monroe era altro che i suoi tormenti e, infine, che le si sarebbe svolto un miglior servizio inquadrandone il destino in un più equilibrato racconto di alti e bassi anziché questo angosciante precipizio che assume le forme di un delirio paranoide.


Detto altrimenti, si sarebbe voluto un film di Ron Howard e non di Andrew Dominik. Dal canto suo, il regista neozelandese è chiaro sin dal titolo: Blonde non è una storia sulla vita di Norma Jeane Mortenson, né una panoramica sull’icona Marilyn Monroe, quanto lo studio straniante di uno sdoppiamento irriducibile. Come la Betty/Diane di Mulholland Drive – o, volendo osare di più sul filo delle convergenze onomastiche, come il Norman/Norma di Psycho (1960) – Norma Jeane, mossa dal sogno/incubo di sfondare a Hollywood, si produce per necessità nel suo doppio; dà vita a un (ultra)corpo, che lei stessa percepisce come estraneo e di cui si domanda a più riprese la sorte una volta che il mondo avrà appreso che a esistere è lei, Norma Jeane e non Marilyn. Un’agnizione che non avverrà mai, dacché il mondo sceglierà infine la bionda Monroe e a lei donerà vita e concretezza d’icona, consentendole di divorare chi le diede vita. E “divorare” è verbo emblematico di quest’incubo digitale, in cui produttori, fotografi, giornalisti, mariti, amanti sono pronti a far banchetto del corpo dell’infelice Norma, ma neppure risparmiano dal loro esecrabile saccheggio il suo ultracorpo, il doppio-Marilyn, che mentre sfila sul tappeto rosso per la prima di A qualcuno piace caldo (1959) vede orrendamente sformarsi le bocche dei fan e reporter che gridano oscenamente al suo indirizzo, come si deformava otticamente il volto della protagonista in una inquietante scena di INLAND EMPIRE.

A dispetto dell’erronea dicitura biopic che ne accompagna la distribuzione, Blonde è in realtà un film di fantasmi – si veda l’ultima inquadratura –, un’opera che demolisce con furia, senza il minimo accenno lirico, il sogno hollywoodiano (e, vorremmo aggiungere, ogni genere di spettacolo di massa), un’opera che ragiona attraverso una rielaborazione dei codici del grottesco lynchiano e del macabro e la cui cifra principe è il disgusto. Un disgusto talvolta fin troppo esibito e corteggiato da un’immagine che non teme di farsi kitsch, come nella spiacevole sequenza dell’aborto o in occasione del miserevole incontro di Norma col presidente Kennedy, culminante in una fellatio forzata, di cui ci rimangono addosso tutto lo squallore e la prepotenza ben oltre i titoli di coda. Si tratta di momenti in cui il sospetto che si sia oltrepassato un limite – non di decenza, si badi, ma di coinvolgimento del pubblico – fa inevitabilmente capolino e non dubitiamo che la sensibilità di qualche spettatore potrebbe venire urtata, ma vorremmo aggiungere, a titolo di correttezza, come in entrambi i casi citati (e i molti non citati ove il cattivo gusto sopravanza) è sempre il punto di vista, l’organizzazione dello spazio dell’inquadratura, in una parola l’immagine a lasciare in noi una impressione tanto forte, segno di un gesto registico che va consapevolmente incontro all’eccesso, come per incollare questa sgradevolezza alla nostra mente, premerla nel nostro immaginario in modo tale che non sia più possibile in futuro ripensare all’icona Monroe con l’innocenza di prima.
Matteo Pernini – MCmagazine 76