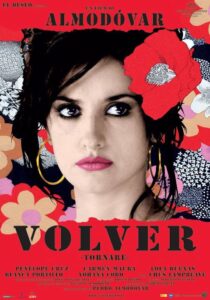Pamela, giovane Rom insolente, spontanea e piena di ironia vive con sua nonna e la sua bambina, ma sogna la libertà e mondi da esplorare. Così, con la speranza di un matrimonio che cambi il suo destino e quello di sua figlia, parte per il Belgio con un vocabolario di solo tre parole (lapin, pizza, amour)… La realtà entra nel meccanismo della finzione con la voglia di ricreare un mondo di volontà e speranze, lineare nello stile, coinvolgente nel pathos.
Seule à mon mariage
Belgio 2018 (122′)

Mantenendo l’apporto adottato per i suoi lavori documentari, avvalendosi della tecnica perfezionata nel diventare presenza concreta nello spazio delle consuetudini riprese, la regista e sceneggiatrice Marta Bergman esordisce in un’opera di fantasia con Sola al mio matrimonio, dove mantiene ben salde quelle capacità acquisite e perfezionate nel corso dei suoi anni nel circoscrivere il vero, modificandone i metodi di applicazioni e rendendoli attinenti al suo nuovo percorso cinematografico.
Sembra partire proprio come la messa a nudo delle condizioni di esistenza della protagonista Pamela (Alina Serban) l’opera Sola al mio matrimonio. Nella comunità rom di cui la donna fa parte, è assieme alla sua bambina e alla nonna insofferente che la giovane vive nell’unica maniera che ha mai conosciuto, alla ricerca di una svolta nella propria vita e di poter allontanarsi dalla povertà che domina la sua quotidianità. Mancanze che Pamela non percepisce solamente in quanto materiali, ma che vuole colmare sotto quell’aspetto emotivo in cui vorrebbe vedersi legata sentimentalmente a un brav’uomo. È tramite un’agenzia di incontri che la donna diventerà, presto, la compagna di Bruno (Tom Vermeir), andando a vivere nella sua casa e tenendolo all’oscuro della sua piccola bambina, decisa a voler cambiare la propria vita.

Oltre all’imprigionare con estrema vicinanza i suoi protagonisti, non riprendendoli, ma entrando nelle loro case, nei loro momenti privati, catturandone le piccolezze rese rilevanti dai dettagli della cinepresa, è il contesto tradizionale e il retaggio di una cultura come quella a cui appartiene il personaggio di Pamela che Marta Bergman integra alla sua storia. Un attingere da un focolare primo per illustrare, conseguentemente, le pulsioni e i comportamenti dei personaggi, ulteriore specchio antropologico e sociale che la regista porta inevitabilmente nel proprio bagaglio e di cui decide di riempire anche il suo film.

Così, seguendo Pamela e il suo desiderio di distaccarsi dalla propria comunità, augurandosi un futuro ben differente da quello che l’aspetterebbe se rimanesse legata alle proprie radici, l’opera mette in relazione le incongruenze di genere, di ambiente culturale, tutto su di un piano comune che l’autrice tratteggia lungo il corso della pellicola, cercandone certamente il pathos, ma permettendo alle immagini di parlare ben più di quanto una narrazione canonica potrebbe fare. Una maniera a cui va contribuendo la scelta della fotografia e dell’illuminazione granulosa di Jonathan Ricquebourg, nonché la credibilità dell’attrice protagonista Alina Serban, i cui primi piani ne permettono uno scrutare attento e sincero, che spetta al pubblico cogliere e decifrare. Pur descrivendo con sentimento le aspettative del personaggio principale, nonché le relazioni che questo intraprende con tutte le altre personalità che gravitano attorno alla sua vita e alle sue scelte, Sola al mio matrimonio rischia di appesantire un racconto che, nel suo insieme, sa comunque restituire le intenzioni della sua autrice, non entusiasmando con particolari doti espressive, ma pur sempre mantenendo il punto e l’analisi che Marta Bergman ne voleva dare.
Martina Barone – cinematographe.it